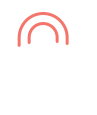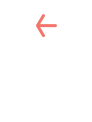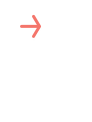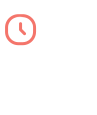Marzo 1949: “Il Ponte”, la prestigiosa e autorevole rivista fondata e diretta da Piero Calamandrei dedica il suo intero fascicolo alle “Carceri: esperienze e documenti”. Testi di Calamandrei, Carlo Levi, Riccardo Bauer, Mario Vinciguerra, Ernesto Battaglini, Massimo Mila, Vittorio Foa, Leone Ginsburg, Altiero Spinelli, Augusto Monti, Guglielmo Petroni, Bice Rizzi, Giancarlo Pajetta, Giovanni Paroli, Lucio Lombardo Radice, Umberto Ceva, Luciano Bolis, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Adele Bei, Pasquale Manconi, Alessandro Policetti, Ester Parri, Emilio Lussu, Vincenzo Baldazzi, Franco Antonicelli, Francesco Fancello, Bruno Corbi, Michele Giuia, Arnaldo Banfi, Corrado Tumiati.
Quello che segue è l’editoriale che “apre” quel fascicolo speciale de “Il Ponte”. Nonostante i suoi 75 anni nulla ha perso della sua attualità. Fin dal titolo: “Bisogna aver visto”.
“Le carceri italiane… rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più̀ atroce che si sia mai avuta: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori…”.
Queste sono parole di Filippo Turati: le pronunciò alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904, in un discorso memorabile, che poi fu pubblicato in opuscolo sotto il titolo “Il cimitero dei vivi”.
Le carceri italiane, cimitero dei vivi; erano così cinquant’anni fa, sono così oggi, quasi immutate. Alla fine di quel discorso il Turati, dopo aver descritto quelle prigioni che egli stesso, pochi anni prima, aveva esperimentate come recluso politico, si diceva sicuro che “i nostri figli, ne ho la convinzione, ricordando l’attuale sistema carcerario italiano, lo considereranno con quello stesso senso di orrore con cui noi guardiamo, quando andiamo in Castel Sant’Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e le altre segrete del Medioevo…”.
Era troppo ottimista: i figli sono cresciuti, sono cresciuti i nipoti; ma il nostro sistema carcerario medievale è rimasto com’era. Anzi, sotto qualche aspetto, è peggiorato; perché́ se nei primi quindici anni di questo secolo, per la tenacia di apostoli isolati, si vide sorgere anche in Italia qualche stabilimento carcerario modello ispirato a criteri civili di igiene e di umanità̀, la coalizione generale delle carceri è oggi ricaduta negli orrori dì un tempo. E ciò̀ per due ragioni: sotto l’aspetto edilizio ed igienico, perché́ la seconda guerra mondiale, con tutte le rovine da essa causate, ha distrutto anche numerosi stabilimenti di pena, in modo che oggi anche nelle prigioni vi è una spaventosa crisi degli alloggi, che condanna a rimanere stivata in locali diminuiti di numero e ridotti spesso a nude mura, una popolazione carceraria sovrabbondante; e più sotto l’aspetto spirituale, perché́ il passaggio del ventennio fascista ha deliberatamente portato nella disciplina dei reclusori, colla riforma della legislazione penale e dei regolamenti carcerari, un soffio di gelida crudeltà̀ burocratica e autoritaria, che senz’accorgersene sopravvive al fascismo.
Se oggi nella stampa è diventato un episodio ordinario di cronaca nera, che lascia indifferenti i lettori, il fatto di detenuti che soccombono alle sevizie inflitte loro nel carcere, si deve ringraziare ancora quel celebre art. 16 del Codice, di procedura penale del 1930, che garantendo praticamente l’impunità agli agenti di pubblica sicurezza “per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”, costituiva una specie di tacita istigazione alla tortura. Del cupo spirito che alimentava il regolamento carcerario del 1931 dovuto al guardasigilli Alfredo Rocco, scriverà̀ in questo fascicolo Mario Vinciguerra: ma non si deve dimenticare che nell’inasprire il sistema penale e penitenziario, il ministro era ben d’accordo col suo padrone. Quando, al congresso di una società̀ che continuava a intitolarsi al “progresso delle scienze”, si trovò un professore ordinario di diritto penale che dedicò un panegirico alla “funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini”, il festeggiato, che aveva concesso a quei bravi scienziati la degnazione della sua presenza, volle benignarsi di aggiungere egli stesso qualche parola a illustra- zione di sé medesimo; e pronunciò anche in quella occasione alcune di quelle frasi lapidarie colle quali soleva inchiodare la storia. In polemica contro coloro che “si erano agganciati all’antropologia “criminale”, egli in quattro battute sventò i pregiudizi di chi si ostinava a fare apparire Beccaria come contrario alla pena di morte.
“… Io avevo avuto sempre l’impressione che molti di coloro i quali si riferivano a Cesare Beccaria, in realtà̀, come spesso succede, non avevano letto il suo libro “Dei delitti e delle pene”. Io mi volli documentare e chiesi alla biblioteca Sonzogno quel volumetto di proporzioni minuscole che, ognuno di voi, probabilmente può̀ facilmente acquistare. E allora – controllate, vi prego, se io dico il vero – venni a questa semplice constatazione: che Cesare Beccaria non era affatto, contrario alla pena di morte…”.
E poi, anche a proposito delle carceri, egli portò, come soleva, il verbo definitivo: mise in guardia coloro che studiano le carceri, dal vedere questa umanità̀ sotto un aspetto forse eccessivamente simpatico…. Credo che sia prematuro abolire la parola pena e credo che non sia nelle intenzioni di alcuno convertire le carceri in collegi ricreativi piacevoli, dove non sarebbe poi tanto ingrato il “soggiorno”. Difatti la storia, fedele alla consegna, assicura che il fascismo non convertì le carceri in collegi ricreativi piacevoli.
E tuttavia, anche se la condizione delle carceri è ricaduta a quella che era mezzo secolo fa, vi è oggi nella vita pubblica italiana un elemento nuovo, che potrebbe essere decisivo per una fondamentale riforma di esse. Se nel 1904 gli uomini politici che avessero esperienza della prigionia si potevano contare nella Camera italiana sulle dita di una mano, oggi nel Parlamento della Repubblica essi sono certamente centinaia; solo nel Senato siedono diverse diecine di senatori di diritto che hanno scontato più di cinque anni di reclusione per condanna del Tribunale speciale.
Mai come ora è stata presente nella nostra vita parlamentare la cupa esperienza dolorante della prigionia vissuta; se neanche questa volta sì facesse qualcosa per cominciare a portare un po’ di luce di umanità̀ nel buio delle carceri, non si potrebbe addurre questa volta la comoda scusa burocratica della mancanza di precise informazioni!
Nel 1904 Filippo Turati propose una commissione di inchiesta: “se volete una commissione efficace in questa materia non la dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocrati, pieni di esperienza legislativa o regolamentare, ma dovete cercare delle forze vive, degli apostoli veri, che abbiano il coraggio di squarciare i veli, di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro sistema carcerario”. Ma il ministro del tempo si oppose alla proposta; gli pareva una menomazione della sua autorità̀ di governo.
Una inchiesta analoga è stata nuovamente proposta nel 1948. Questa volta la proposta, sia pure in una forma un po’ attenuata, è stata accolta da un guardasigilli di più̀ largo ed umano respiro. La nomina di una commissione è stata promessa: essa potrà̀ avere il vanto di esser composta in gran parte di deputati e di senatori ex reclusi, che quando andranno a visitare le prigioni vi ritroveranno sulla soglia l’ombra del loro dolore e la guida scaltrita della loro consapevolezza.
Intanto, in attesa che la promessa sia mantenuta, si cominciano a radunare in questo fascicolo le testimonianze di coloro che hanno sofferto questi inumani orrori: che son motivo di fierezza per chi ora può ricordare vivo dì averli affrontati in difesa dì un’idea; ma che sarebbero, per quel governo che conoscendoli continuasse d’ora innanzi a non far nulla per portarvi rimedio, motivo di infamia.
(da “Il Ponte”, rivista di politica e letteratura diretta da Piero Calamandrei, anno 1949)
Calamandrei: Onorevoli colleghi, al Senato è stato parlato lungamente delle carceri. È un argomento sul quale, credo che quello che dirò non potrà suscitare opposizione o interruzioni da nessuna parte. Si è parlato lungamente delle carceri e ne hanno parlato soprattutto coloro che più avevano il diritto di parlarne, cioè̀ quelli che vi sono stati lungamente, che vi hanno sofferto e che hanno sperimentato quel che vuol dire esser recluso per dieci o venti anni.
Signor Ministro, alle raccomandazioni fatte al Senato sulla necessità di una riforma fondamentale dei metodi carcerari e degli stabilimenti di pena, ella ha risposto dando generiche assicurazioni. Ora, io vorrei che non ci si contentasse di assicurazioni non impegnative, come tutti i Ministri – anche quando sono seri e coscienziosi come ella è – sono disposti a dare, nel rispondere alle osservazioni che si fanno sui loro bilanci. Io vorrei che da questa esperienza di dolore che colleghi di questa Camera e del Senato hanno sofferto, nascesse per l’avvenire un effetto di bene. Questo mistero inesplicabile della vita umana che è il dolore, si può̀ forse avvicinarsi a spiegarlo, soltanto quando si pensi che il dolore di un uomo possa servire a risparmiare il dolore ad altri uomini; e allora si sente che anche il dolore può avere la sua ragione. Ora, questa esperienza di dolore che i nostri colleghi hanno fatto non deve andare perduta. In Italia il pubblico non sa abbastanza – e anche qui molti deputati tra quelli che non hanno avuto l’onore di esperimentare la prigionia, non sanno – che cosa siano certe carceri italiane.
Bisogna vederle, bisogna essere: stati, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d’appello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché́ soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe esser pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima esperimentato quella realtà̀ sulla quale deve sorvegliare. Vedere! questo è il punto essenziale. Per questo, signor Ministro, ho presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di nominare una Commissione d’inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano inclusi in gran numero coloro che hanno sperimentato la vita dei reclusori; in modo che gli esperti possano servir di guida agli altri in queste ispezioni che dovrebbero compiersi non con visite solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi, ad uno ad uno, a tu per tu, da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà̀ sapere come veramente si vive nelle carceri italiane. Voi sapete che quel sorprendente opuscolo che costituisce una delle glorie più̀ grandi della civiltà̀ italiana, quel miracoloso libretto “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, che riuscì̀ ad abolire in pochi anni in Europa la tortura e la pena di morte, è nato, direi quasi, per caso, proprio perché́ qualcuno aveva visto come si viveva e si soffriva nelle prigioni. Il Beccaria non era un giurista, era un economista: andava la sera in casa degli amici conti Verri, uno dei quali, Alessandro, ricopriva in quegli anni il pietoso ufficio di “protettore dei carcerati”. La sera Alessandro raccontava agli amici quello che aveva visto nell’esercitar quella sua missione caritatevole: gli orrori di quelle carceri, le sofferenze di quei torturati; e il Beccaria ne rimase talmente turbato che non come un trattato scientifico, ma come un grido di angoscia sentì uscir dal suo cuore quelle poche pagine che bastarono in pochi anni a travolgere in tutta l’Europa i patiboli e gli strumenti di tortura.
Ora, onorevoli colleghi, questo bisogna confessar chiaramente: che oggi in tutto il mondo civile, nella mite ed umana Europa, a occidente o a oriente e anche in Italia (ma forse in Italia meno che in altri Paesi d’Europa) non solo esistono ancora prigioni crudeli come ai tempi di Beccaria, ma esiste ancora, forse peggiore che ai tempi di Beccaria, la tortura!
Questi sono argomenti sui quali di solito si ama di non insistere; si preferisce scivolare e cambiar discorso. Eppure, bisogna avere il coraggio di fermarcisi. Ai primi di settembre, al congresso dell’Unione parlamentare europea ad Interlaken, al quale intervennero numerosi colleghi che vedo presenti in quest’aula, ci accadde, nel discutere un disegno preliminare di costituzione federale europea, di imbatterci in un articolo, che nella sua semplicità̀ era più̀ terribile di qualsiasi invettiva: “È vietata la tortura”. Nel leggerlo, abbiamo provato un’impressione di terrore: in Europa. nel 1948, c’è dunque ancora bisogno di inserire nel progetto di una costituzione federale, da cui potranno essere retti domani gli Stati uniti d’Europa, questa avvertenza? Le costituzioni, come voi sapete, hanno quasi sempre, nelle loro norme, un carattere polemico: le leggi nascono dal bisogno di evitare ciò̀ che purtroppo si pratica. Ora il fatto che si senta il bisogno di vietare nella civile Europa la tortura vuol dire che nella civile Europa la tortura è tornata in pratica. E quando io parlo della tortura, non intendo riferirmi a quelle crudeltà̀ che, talvolta, per malvagità̀ individuale o per follia (come pare sia accaduto nell’episodio di Poggioreale) secondini o agenti, per fortuna costituenti rare eccezioni, possono esercitare sui reclusi per punirli; quando io parlo della tortura, intendo riferirmi a quel metodo di indagine inquisitoria che esisteva come procedimento legale fino a metà del secolo XVIII nei giudizi penali, prima che fosse abolito, per merito soprattutto del Beccaria. È noto che nella procedura penale, fino alla metà del secolo XVIII, la tortura era un mezzo probatorio, disciplinato dalle leggi e studiato dai trattatisti, mirante a costringere l’imputato a confessare. Si riteneva che l’imputato avesse il dovere di confessare e di dire là verità̀ anche contro sé stesso; e quindi, per costringere l’imputato inquisito a eseguir questo suo dovere, si adoperava su di lui la coercizione corporale, modo legale per provocare la confessione. Orbene, onorevoli colleghi, la tortura come mezzo per ricercare la verità̀ rientra anche oggi, non di rado, tra i metodi della polizia investigativa: in tutto il mondo, in tutti i paesi civili, ed anche in Italia.
Voi ricordate il caso Fort: allora tutti i giornali ci raccontarono con ricchezza di particolari il modo con cui l’imputata era stata indotta a confessare, interrogandola ininterrottamente per ottanta ore di seguito, impedendole di dormire, di distrarsi, forse anche di mangiare e di bere, tenendola inchiodata quattro giorni e quattro notti e più, sotto la luce accecante delle lampade concentrate su di lei. Allora io presentai una interrogazione al Guardasigilli del tempo; ma le vicende parlamentari non permisero al Ministro di darmi una risposta: ebbi però altre risposte, numerose lettere anonime che mi ricoprivano di vituperi (questo è il livello dell’opinione pubblica in Italia) perché́, se avessi protestato contro quei metodi, avrebbe voluto dire che io ero complice dei delitti attribuiti a quella imputata! Ma il caso Fort, onorevoli colleghi, non è isolato. Ho voluto fare, in questi ultimi mesi, una specie di inchiesta privata e discreta fra gli avvocati e i magistrati: vi assicuro che ho raccolto materiali impressionanti, sui quali non voglio darvi qui particolari; ma li potrei dare al Ministro quando me li chiedesse (ma non me li chiederà̀). Gli avvocati interpellati mi hanno risposto in via confidenziale, ma mi hanno fatto promettere di non dir pubblicamente i loro nomi, perché́ essi sanno che se, nel rivelare quei metodi, precisassero dati e circostanze, verrebbero a danneggiare i loro patrocinati: li esporrebbero a rappresaglie, a persecuzioni, forse a imputazioni di calunnia, perché́ di fronte alle loro affermazioni non si troverebbe il testimone disposto a confermare che quanto dice l’imputato è vero. Accade così che il difensore, anche quando sa che il suo patrocinato è state oggetto di vera e propria tortura per farlo confessare, lo esorta a sopportare e a tacere, a non rivelare in udienza quei tormenti ai quali, in mancanza di prove, i giudici non credono.
Ho parlato di questo anche con qualche magistrato, anche con giudici istruttori. Uno di essi mi ha detto: “Mi sono trovato talvolta di fronte a casi inesplicabili. Ho visto, per esempio, studiando i verbali raccolti dalla polizia, un imputato che in dieci verbali si è mantenuto negativo; all’undicesimo, improvvisamente, ha fatto una confessione piena e particolareggiata; ma al dodicesimo verbale si è ritrattato e in seguito si è mantenuto ostinatamente negativo. Allora ho interrogato l’imputato per chiedergli il perché́ di questi mutamenti e quello mi ha risposto: “quando fui libero di rispondere secondo verità̀ dissi di no: ma una volta, quella volta, non potei reggere al dolore: e dissi di sì”.
Ma i metodi per far dire di sì agli imputati, dei quali ho raccolto notizie nella mia inchiesta, non voglio descriverveli”.
Voci all’estrema sinistra: “Li sappiamo!”.
Calamandrei: “Appunto perché́ c’è tra noi chi li sa, bisogna diffondere tra tutti gli uomini onesti questa conoscenza ed unirci per far sì che questa infamia cessi.
Io le dico, signor Ministro, che, se ella riuscisse, nel periodo in cui ella rimarrà̀ Guardasigilli, a cancellare dalla vita carceraria e dai metodi investigativi questi ritorni di barbara crudeltà̀, questo basterebbe per darle gloria nella storia della nostra civiltà̀ e delle nostre leggi.
Purtroppo, in questo raffinamento di ferocia, entra spesso anche la scienza: tortura non è soltanto la crudeltà̀ individuale violenta e bestiale, ma è anche tortura l’adoperare sull’imputato metodi a base cosiddetta psicologica intesi a limitare o a vincere con farmaci o stupefacenti la sua libertà morale. Bisogna persuadersi che fra le libertà essenziali e fondamentali della persona umana vi è la libertà di non confessare, la libertà di mantenere il segreto della propria coscienza. Se esiste, consacrato in un articolo della Costituzione, il rispetto del segreto epistolare e telegrafico, se esiste l’inviolabilità̀ del domicilio, deve esistere, a maggior ragione, l’inviolabilità̀ di questo rifugio spirituale che ciascuno di noi chiude dentro di sé e del quale soltanto la libera volontà̀ può̀ aprire le porte; ogni metodo volto a coartare questa volontà̀, a indebolirla con farmaci o con ipnotici per indurla ad aprire i suoi segreti, anche se si tratta del così detto “siero della verità̀” o di altri metodi scientifici adoperati dalle polizie moderne organizzate meglio della nostra, tutto questo è un’offesa e un tradimento alla persona umana, alla quale bisogna ribellarsi. Anche l’imputato è un uomo, e forse è un innocente: l’unico metodo per indurre un uomo a rivelar quello che ha nella coscienza e a confessar le sue colpe è quello di persuaderlo col ragionamento; ma se non vuole confessare, egli ha diritto di non volere: egli ha questa libertà del segreto, che forse è la più̀ sacra e la più̀ intima delle libertà̀ del cittadino”.
(Seduta del 28 ottobre 1948)
Presidente: “Chiedo all’onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo sui seguenti ordini del giorno presentati: “La Camera invita il Governo a nominare una Commissione di inchiesta, composta di deputati e senatori, allo scopo di indagare e riferire al Parlamento sui metodi di investigazione adoprati dalla polizia per ottenere la confessione degli arrestati, sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, sui metodi adoprati dai personale carcerario per mantener la disciplina tra i reclusi”.
Grassi, Ministro di grazia e giustizia. “Ella, onorevole Calamandrei, mi ha invitato a fare una passeggiata insieme nelle carceri; ci verrò volentieri, ma un’inchiesta mi pare francamente esagerata. Questo per quanto riguarda le carceri; circa poi gli interrogatori, la competenza a provvedere non è del Ministero della giustizia. Io penso che il rimedio efficace ai lamentati inconvenienti noi lo troveremo quando in attuazione dell’ordinamento giudiziario la polizia giudiziaria passerà veramente a disposizione dei magistrati. Allora soltanto tali eccessi di tortura fisica e morale, tanto deplorevoli, verranno a cessare, ma in questo momento io come Guardasigilli, non posso assumere degli impegni che esulano, come ho detto, dalla competenza del mio Ministero. Accolgo ad ogni modo l’ordine del giorno come raccomandazione, e prego l’onorevole Calamandrei di non voler insistere sulla proposta di una Commissione d’inchiesta”.
Calamandrei: “Chiedo di parlare, se ne ho la possibilità̀ secondo il Regolamento”.
Presidente: “In realtà̀ ella non potrebbe parlare a meno che non voglia dichiarare le ragioni per cui ritira il suo ordine del giorno. Tuttavia, se sarà̀ brevissimo non ho difficoltà a consentirle di parlare”.
Calamandrei: “Vorrei dire ai colleghi soltanto questo: che quando ieri ad un certo punto del mio discorso ho sentito l’onore, troppo superiore ai miei meriti, di un applauso unanime di tutta la Camera, questo è stato forse il momento più̀ felice di tutta la mia vita parlamentare, perché́ mi sono accorto che anche in una Camera divisa da una profonda frattura politica come l’attuale, quando si toccano certi punti di umanità̀, in cui tutti ci ritroviamo uomini, possiamo essere tutti d’accordo nel cercare di fare del bene ad altri uomini.
E, quindi, non riesco a capire perché́, di fronte ad una proposta la quale non chiede al Governo denari, perché́ si tratta semplicemente di fare una Commissione d’inchiesta di deputati e senatori, la quale in sostanza non dà a questi deputati e senatori facoltà̀ diverse da quelle che essi isolatamente hanno – perché́ ogni deputato e senatore può̀ andare nei reclusori e nelle case di pena a vedere e a domandare – ma ha soltanto lo scopo di riunire insieme persone volonterose di raggiungere questo scopo comune e di mettere a contatto persone che come me, non hanno avuto l’onore dell’esperienza del carcere, che con questi nostri colleghi migliori di noi che l’hanno avuta – uomini di tutti i campi, di sinistra e di destra -; non riesco a capire, dicevo, che per motivi di schermaglia parlamentare ci si debba trovare in disaccordo!
E proprio per questo mantengo il mio ordine del giorno, onorevole Ministro, e mi auguro che una volta tanto, al di sopra di ogni frattura politica, ci si trovi fraternamente uomini per un interesse e uno scopo umano di bene”. (Applausi a sinistra e alla estrema sinistra).
Tambroni: “Chiedo di parlare per dichiarazione di voto”.
Presidente: “Ne ha facoltà̀”.
Tambroni: “Una brevissima dichiarazione di voto anche a nome di altri colleghi del mio Gruppo. Prego, intanto, l’onorevole Presidente di mettere in votazione l’ordine del giorno Calamandrei per divisione. Dichiaro di essere contrario e di votare contro la prima parte, quella che riflette la nomina d’una Commissione d’inchiesta relativa ad accertare le pressioni della polizia per ottenere la confessione dei prevenuti. E ne dico la ragione. Innanzitutto, un’inchiesta di tal genere investe anche un problema di politica interna in senso generale, ma soprattutto investe la funzione della magistratura, perché́ è notorio che allorché́ un arrestato, dopo essere stato interrogato dalle autorità̀ di polizia, è portato al cospetto del giudice, se per avventura egli ha subito delle violenze o ha dovuto soggiacere a pressioni, ha la più ampia possibilità̀ di denunciare ciò al magistrato”.
Una voce all’estrema sinistra: “Non è mai creduto”.
Tambroni: “E il nostro Codice prevede gravi sanzioni nei confronti degli agenti di polizia. Posso aggiungere che recentemente ho difeso un brigadiere di pubblica sicurezza, perché́ nell’esercizio delle sue funzioni aveva tentato di estorcere con la violenza una dichiarazione a un detenuto.
Per quanto riguarda la seconda parte (che dichiaro di votare) pregherei l’onorevole Calamandrei di non fermarsi alla Commissione d’inchiesta: io proporrei una Commissione permanente di vigilanza sulle condizioni dei detenuti e sui metodi adoperati dal personale carcerario. Posso dire che veramente di una Commissione o di un Comitato permanente di senatori e deputati v’è bisogno perché́, senza recare nessuna offesa alla grande famiglia degli agenti di custodia, è peraltro vero che molte volte essi esagerano o addirittura superano i limiti di umana sopportazione nell’applicazione della disciplina.
Ed è per questo che sono favorevole, proprio per quel solidarismo umano cui ha accennato l’onorevole Calamandrei, non alla nomina di una Commissione d’inchiesta, ma alla nomina di un Comitato parlamentare permanente di vigilanza e di controllo sull’andamento delle nostre carceri. L’onorevole Ministro mi consenta di aggiungere che egli non può̀ e non deve interpretare come atto di sfiducia un voto di questa natura, perché́ si tratta qui, anche in questo settore, di migliorare, nell’interesse della civiltà̀, gli istituti di prevenzione o di pena”. (Applausi).
Presidente: “L’onorevole Ministro della giustizia ha facoltà̀ di dichiarare il parere del Governo su questa nuova proposta”.
Grassi, Ministro di grazia e giustizia: “Nella maniera e nel tono come è stata fatta la proposta dell’onorevole Tambroni, non ho nessuna difficoltà ad accettarla, e vi assicuro che le parole dette dall’onorevole Calamandrei non hanno trovato ieri un’eco soltanto nel cuore della Camera, ma anche nel mio. Non potevo consentire che venisse fatta una inchiesta contro la mia amministrazione, ma nulla ho in contrario a che, con la creazione di una Commissione di vigilanza, siano rafforzate quelle disposizioni già̀ esistenti nel regolamento carcerario sull’opera di controllo e sorveglianza da parte dei membri del Parlamento relativamente alla situazione carceraria. Mi conforta anzi il pensiero che questa Commissione potrà̀ sicuramente dare maggiore forza alla mia attività̀ e alle mie richieste tendenti a ottenere i mezzi necessari per l’attuazione di quei miglioramenti delle condizioni dei detenuti, da tutti tanto attesi”. (Applausi).
Presidente: “Pertanto, secondo la proposta Tambroni, accettata dal Governo, l’ordine del giorno potrebbe essere così formulato: “La Camera invita il Governo a nominare una Commissione permanente, composta di deputati e senatori, allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi”.
Chiedo all’onorevole Calamandrei se accetta questa nuova formulazione”.
Calamandrei: “Nel mio ordine del giorno vi erano due oggetti: uno è quello della vigilanza sulle condizioni dei detenuti nelle carceri, l’altro è quello sui metodi della polizia. Ma siccome questi due argomenti possono essere scissi, e siccome su questo secondo argomento io potrò̀ ripresentare una interpellanza o una mozione, oggi per ottenere almeno su uno di questi due punti un voto unanime, accetto questa modificazione della mia proposta, pur facendo osservare al signor Ministro Guardasigilli, il quale sa la cordialità̀ che io ho verso lui e quindi non può̀ avere interpretato come mancanza di fiducia in lui il mantenimento di questo ordine del giorno, che la modificazione viene a rafforzare, in un certo senso, la mia proposta, perché́ io mi contentavo di una Commissione d’inchiesta una volta tanto, mentre con questa proposta verrà̀ una Commissione permanente, il che sarà̀ meglio. Questa è la ragione per la quale accetto questo emendamento”.
Presidente: “Debbo ora porre in votazione l’ordine del giorno nella formulazione concordata testé letta”.
Mannironi: “Chiedo di parlare”.
Presidente: “Ne ha facoltà̀”.
Mannironi: “Vorrei rilevare che, dato che si tratta di una Commissione parlamentare, non dovrebbe essere nominata dal Governo, ma dalla Camera o dalla Presidenza della Camera”.
Presidente: “La prassi che si segue in questi casi è la nomina da parte governativa su designazione da parte del Parlamento, giacché la rappresentanza è di ambedue i rami del Parlamento. Io non trovo, nella dizione dell’ordine del giorno, niente che non rispecchi quella che è stata la prassi adottata in casi simili. Onorevole Mannironi, ella insiste nella sua obiezione?”.
Mannironi: “Non insisto”.
Presidente: “Sta bene. Pongo in votazione l’ordine del giorno Calamandrei con le modificazioni proposte dall’onorevole Tambroni e accettate dallo stesso onorevole Calamandrei e dal Governo”. (È approvato all’unanimità̀. – Vivissimi applausi)